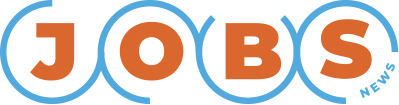Riscaldamento, l’elettrodomestico colpevole dei rincari lo usi ancora tutti i giorni: staccalo subito
Bolletta energia elettrica - fonte_depositphotos - Jobsnews.it Per il tuo riscaldamento utilizzi un elettrodomestico che se non lo stacchi subito sarà letteralmente la tua rovina,...

Lavori senza laurea, se hai queste competenze il foglio non ti serve: contratto sicuro se ti candidi oggi
Laurea - fonte_depositphotos - jobsnews.it Numerosi i lavori che si possono svolgere anche senza avere la laurea. Per riuscire a non essere un disoccupato ti...

Disoccupazione, con questo test il nuovo lavoro è assicurato: il risultato non sbaglia mai | Lo dice la scienza
Test per trovare lavoro - fonte_depositphotos - jobsnews.it Trovare lavoro non sempre è semplice, ma se ti sottoponi a uno specifico test allora potresti vedere...

Tari, sconto dell’80% dedicato a pochissimi: se sei fortunato rientri in questa lista e risparmi una fortuna
Tari - Depositphotos - JobsNews.it Se si rientra in una specifica lista si può arrivare a risparmiare fino all'80% sulla Tari. Per quanto riguarda la...

Aumento busta paga in arrivo, 1200 euro regalati dallo Stato a partire da questa data: controlla il cedolino
Busta paga - Depositphotos - JobsNews.it A partire da una determinata vi sarà un aumento della busta paga di ben 1200 euro. A partire dal...
Lavoro
Lavori senza laurea, se hai queste competenze il foglio non ti serve: contratto sicuro se ti candidi oggi
Laurea - fonte_depositphotos - jobsnews.it Numerosi i lavori che si possono svolgere anche senza avere la laurea. Per riuscire a non essere un disoccupato ti...
Disoccupazione, con questo test il nuovo lavoro è assicurato: il risultato non sbaglia mai | Lo dice la scienza
Test per trovare lavoro - fonte_depositphotos - jobsnews.it Trovare lavoro non sempre è semplice, ma se ti sottoponi a uno specifico test allora potresti vedere...
Aumento busta paga in arrivo, 1200 euro regalati dallo Stato a partire da questa data: controlla il cedolino
Busta paga - Depositphotos - JobsNews.it A partire da una determinata vi sarà un aumento della busta paga di ben 1200 euro. A partire dal...
Pause al lavoro, occhio all’orologio: se superi quest’orario sono guai | Non farti beccare o ti licenziano
Pausa a lavoro - fonte_depositphotos - jobsnews.it Quando si va in pausa dal lavoro conviene tenere sott’occhio l’orologio, se si supera un certo orario si...
Lavoro, la lavanderia la paga il capo: questa categoria è la più fortunata di tutte | Vestiti puliti completamente gratis
Lavanderia -fonte_depositphotos - jobsnews.it Per questa categoria la lavanderia diventa un benefit. Possono avere i vestiti sempre puliti in maniera completamente gratuita. Alcune specifiche categorie...
Poste italiane in crisi, ricercati 1000 dipendenti per la stagione estiva: se fai domanda ora il posto è tuo
Poste Italiane - Depositphotos - JobsNews.it Per affrontare la crisi in Poste Italiane si cercano 1000 dipendenti per poter svolgere il lavoro nel periodo estivo....